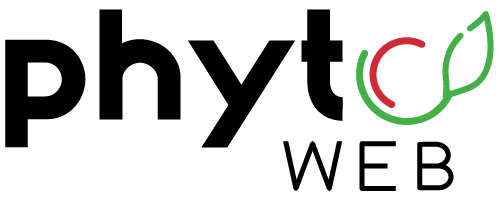Alberature sempreverdi: bellezza, valore e vulnerabilità fitosanitaria
- News
- 2 Settembre 2025

Le alberature sempreverdi rappresentano un pilastro del paesaggio urbano e ornamentale italiano ed europeo.
Non si tratta solo di elementi ornamentali, ma di infrastrutture verdi che svolgono funzioni ecologiche e ambientali di primaria importanza: agiscono come barriere naturali contro l’inquinamento, contribuiscono a mitigare le isole di calore urbane e offrono rifugio alla fauna. La presenza della chioma durante tutto l’anno le espone però a rischi specifici, rendendole particolarmente vulnerabili a parassiti e patogeni che ne minacciano la vitalità.
La globalizzazione e il crescente scambio di piante e materiali vegetali hanno favorito, infatti, la diffusione di organismi alieni capaci di destabilizzare interi ecosistemi, con conseguenze economiche e paesaggistiche rilevanti.
Xylosandrus compactus: il coleottero che mina le chiome
Tale coleottero scolitide, oggi diffuso in molte aree mediterranee, è capace di attaccare numerose specie ornamentali e forestali, tra cui lecci, allori, cipressi, castagni, magnolie e pini, e per questo è classificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea.
Le femmine adulte scavano gallerie nei rami e fusti, interrompendo la circolazione linfatica e trasmettendo funghi patogeni che compromettono la vitalità delle piante. Riconoscere i sintomi precoci, ovvero segatura alla base dei fori, avvizzimento, disseccamento improvviso e perdita della chioma, è fondamentale per attivare misure tempestive.
Un efficace piano di gestione prevede la corretta gestione agronomica, il monitoraggio del volo degli adulti nel periodo tra marzo e ottobre, la rimozione tempestiva delle branche compromesse e la loro distruzione mediante bruciatura o tramite i trattamenti abbattenti autorizzati per i coleotteri xilofagi, da eseguire nei vivai.
Aleurocanthus spiniferus: l’aleurodide che colpisce gli agrumi
Questo aleurodide è una delle minacce più problematiche per l’Europa mediterranea. L’elevata adattabilità climatica e la sua estrema polifagia sono le motivazioni alla base della sua inclusione tra gli organismi nocivi da quarantena prioritari per l’Unione Europea. Sono oltre cento, infatti, le specie vegetali ospiti: dagli agrumi alle piante ornamentali come camelie e rose, fino a diverse colture frutticole e forestali.
Le forme giovanili si nutrono della linfa vegetale delle superficie fogliari, mentre la melata zuccherina prodotta favorisce lo sviluppo della fumaggine, che riduce la capacità fotosintetica e respiratoria delle piante e dei frutti, portando al disseccamento.
La gestione di questo organismo nocivo si basa sulla delimitazione delle aree infestate, potature mirate e distruzione tramite bruciatura delle parti infestate, accompagnate dall’applicazione di trattamenti insetticidi autorizzati in vivaio, in pieno campo o in serra, per limitare la diffusione dell’insetto.
Paysandisia archon: la falena killer delle palme
La grande falena sudamericana, ormai nota nei contesti urbani europei, non è classificata come organismo da quarantena, ma è comunque sottoposta a regolamentazioni fitosanitarie in diversi Stati membri per il suo impatto distruttivo sulle palme.
Le larve scavano gallerie nel fusto, distruggendo i tessuti conduttori e portando all’indebolimento e collasso della pianta. I sintomi includono ingiallimento, appassimento, emissione di rosura, deformazioni nelle foglie con lesioni circolari, gallerie sullo stipite e fori visibili sui fusti.
Il controllo di questo insetto può essere effettuato attraverso interventi di insetticidi chimici o con prodotti biologici. Il trattamento chimico ha lo scopo di colpire l’insetto quando ancora non è penetrato nella pianta. Alcuni territori stanno sperimentando anche alternative biologiche, tra cui l’uso di nematodi entomopatogeni, che penetrano in profondità e colpiscono le larve. Quando invece il danno è ormai irreversibile, l’unica misura rimane l’eliminazione dell’esemplare colpito.
In un panorama dove gli organismi nocivi mettono a dura prova la stabilità del comparto ornamentale, la chiave sta nell’anticipare i problemi e ridurre l’esposizione ai rischi. A supporto degli operatori del settore c’è Phytoweb, piattaforma digitale in cui il florovivaista può verificare in modo semplice le prescrizioni fitosanitarie, comprendere gli obblighi legati alla movimentazione internazionale delle piante e predisporre la documentazione digitale necessaria.
Le alberature sempreverdi rappresentano un patrimonio estetico, ecologico ed economico di inestimabile valore. In questo scenario, strumenti come Phytoweb diventano alleati strategici per la tutela del verde italiano.
ULTIME NEWS

Sicurezza delle piante: l’EFSA segnala 47 minacce fitosanitarie emergenti
L’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha recentemente aggiornato l’elenco degli organismi nocivi prioritari per l’Unione Europea.

Prevenzione, qualità, sostenibilità: il valore di un monitoraggio efficace
Tra cambiamenti climatici, scambi commerciali e crescente pressione fitosanitaria, individuare e prevenire tempestivamente gli organismi nocivi è diventato fondamentale.

Report Nomisma: il florovivaismo italiano tra crescita, competizione e nuove sfide
A delineare il quadro attuale è il nuovo report Nomisma, presentato al convegno “Il verde che esporta: il florovivaismo italiano tra scenari globali e nuove sfide logistiche” organizzato da ANVE in occasione di Greenitaly 2025, che fotografa punti di forza e criticità di un settore in evoluzione.